Le parole di Sergio Mattarella sulla sicurezza del lavoro sono state al centro delle manifestazioni sindacali del 1° Maggio perché la grave questione degli infortuni e delle morti sul lavoro era il tema a cui Cgil, Cisl e Uil hanno voluto dedicare la ricorrenza della Festa del Lavoro. Il capo dello Stato, parlando a Latina, ha voluto affrontare un problema al centro del dibattito politico, citando un recente documento dell’Ocse, nel quale si afferma che l’Italia si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008, nonostante che a partire dal 2022, la produttività sia cresciuta. ‘’Salari inadeguati – ha aggiunto Mattarella sono un grande problema, una grande questione per l’Italia. Incidono anche sul preoccupante calo demografico, perché i giovani incontrano difficoltà a progettare con solidità il proprio futuro.
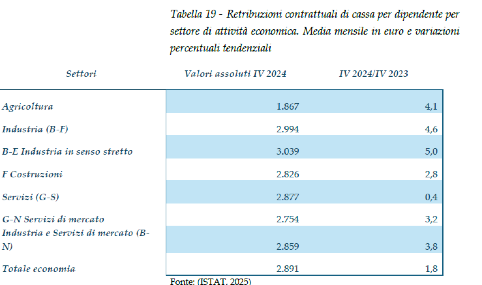
Resta, inoltre, alto il numero di giovani, con preparazione anche di alta qualificazione, spinti all’emigrazione. Questi fenomeni impoveriscono il nostro “capitale umano”. Secondo il XXVI Rapporto del CNEL, infatti, il fenomeno dell’emigrazione dei giovani in altri Paesi (352mila nel corso del decennio 2013/22 nella fascia 25-34 anni, con una tendenza all’aumento del numero complessivo annuo e di quello dei laureati sino al 50%) non compensato dalle quote di ingresso di giovani stranieri in Italia, con le ovvie conseguenze sul piano della demografia, della natalità, della propensione all’innovazione e, quindi, della crescita.
Il doveroso richiamo del Quirinale ha mobilitato le opposizioni politiche e sindacali. I capi gruppo del Pd Francesco Boccia, Chiara Braga e Nicola Zingaretti, in un comunicato congiunto, hanno riproposto la questione del salario minimo al centro del confronto politico. Nel solco della correttezza istituzione che contraddistingue le sue esternazioni, il Capo dello Stato non si era riferito ad alcunché di specifico. Ma tutto sommato la sinistra è ampiamente legittimata a sostenere le sue proposte sul salario minimo (smig), visto che il progetto di legge alternativo, proposto e approvato dalla maggioranza alla Camera, è desaparecido al Senato.
Rimane però una domanda: il salario minimo sarebbe in grado di affrontare il gap retributivo rimproverato al nostro Paese? Secondo le stime dell’INAPP, i lavoratori beneficiari dell’introduzione di un salario minimo legale a 9 euro orari (come propongono le opposizioni) sarebbero circa 2,6 milioni. Di questi, circa 1,9 milioni di lavoratori a tempo pieno (il 18,4% del totale dei dipendenti a tempo pieno) per un costo di 5,2 miliardi, e circa 680.000 lavoratori a tempo parziale (il 29% del totale dei dipendenti part-time) per un costo di 1,5 miliardi. Il costo totale per le imprese sarebbe di 6,7 miliardi di euro. Altre stime sono più prudenti. Emerge, tuttavia, un primo problema: l’effettività di un salario minimo legale dipende dal suo livello. Dovrebbe essere sufficientemente alto per garantire uno standard di vita dignitoso, ma non troppo elevato da superare la capacità di pagamento delle imprese, soprattutto quando l’importo dei 9 euro è stato scelto ‘’a braccio’’.
La direttiva europea forniva delle indicazioni ‘’virtuose’’ per quanto riguarda l’importo dello smig: il 60% del salario mediano e il 50% di quello medio. L’indicazione era di attenersi a questo rapporto, non già di valutare la cifra di per sé paragonandola ad altre che magari sono più elevate in valore assoluto ma inferiori in proporzione al salario mediano o medio. In ambedue i casi del salario di riferimento, lo smig da noi dovrebbe essere di poco superiore ai 7 euro l’ora. Tutto ciò premesso, il salario minimo legale, aumenterebbe sicuramente il monte retributivo, ma non esiste alcuna evidenza che determinerebbe un incremento salariale per tutti i lavoratori, tanto più che – bisognerà pur dirlo – l’Italia perde nel confronto con altri paesi non per il livello delle retribuzioni minime o più basse, ma per quello delle più elevate, dal momento che, nei settori privati, le retribuzioni superiori a 40mila euro l’anno sono soltanto il 9% del totale. Inoltre, 9 euro rappresenterebbero l’87% del salario mediano nazionale (pari a 12,8 euro l’ora).
Va da sé che, con tale base salariale resa obbligatoria per legge, spazi reali di contrattazione verrebbero meno a livello nazionale mentre potrebbero essere recuperati solo attraverso la contrattazione decentrata e di prossimità in relazione con gli incrementi della produttività mediante il vantaggio dei benefici fiscali previsti per gli incrementi salariali collegati al miglioramento della produttività.
In pratica la retribuzione – nel caso di smig a carattere universale – sarebbe contraddistinta da due componenti: una fissata per legge, l’altra contrattata, ognuna delle quali risponderebbe a due differenti autorità salariali, la prima alla mano pubblica chiamata ad adeguare periodicamente il livello, la seconda alla contrattazione collettiva a cui resterebbero a disposizione margini molto limitati, soprattutto nel Mezzogiorno. Sarebbe un ulteriore caso di quella ‘’nazionalizzazione’’ della retribuzione che è la nuova frontiera del socialismo all’italiana.
Ormai ci pensa lo Stato: copre di incentivi le aziende perché assumano; fiscalizza una quota crescente di contribuzione previdenziale per diminuire il ‘’cuneo’’ a favore dei lavoratori; eroga l’assegno di inclusione e altre prestazioni. Se si aggiungesse anche il salario minimo legale, le politiche pubbliche prenderanno il sopravvento sulla contrattazione e ne condizionerebbero l’indirizzo. Poi, lo smig che, in tempi in cui l’inflazione è tornata a farsi viva minacciosa, si trasformerebbe in un’altra scala mobile, inclusa e incorporata nel complesso della retribuzione le cui variazioni periodiche sarebbero affidate ad un’apposita commissione. Sarebbe molto più facile, per i sindacati, sottoporre le loro rivendicazioni all’organo tecnico-politico che tiene sotto controllo il salario minimo, piuttosto che impegnarsi in un negoziato con le controparti; infatti, se i 3/5 della retribuzione fossero definiti da procedure di mano pubblica, anche le relazioni industriali verranno, prima o poi, regolate da un algoritmo.
Bisognerebbe avere il coraggio di andare ai nodi veri: l’architettura della contrattazione collettiva innanzi tutto incentrata in prevalenza sul contratto nazionale di categoria che porta con sé un’inevitabile conseguenza: nel definire le retribuzioni occorre tener conto delle disponibilità delle imprese marginali; i contratti si rinnovano in ritardo. La durata media della vacanza contrattuale in Italia, ovvero il periodo tra la scadenza di un contratto collettivo nazionale e il suo rinnovo è di circa 30 mesi, a cui vanno aggiunti gli anni di validità del contratto; ne deriva che i salari restano al medesimo livello per un lungo arco di tempo col rischio di essere destabilizzati da un imprevisto come una fiammata dell’inflazione rispetto al tasso preso a riferimento al momento del negoziato. E’ quanto è successo negli ultimi anni. Con l’impennata dell’inflazione si è posto un problema di restituzione del fiscal drag, ma si è preferita la via della decontribuzione.
La struttura produttiva italiana, poi, non è adeguata a reggere la sfida della competitività se non attraverso una politica di basse retribuzioni.
I dati ISTAT sulla dimensione d’impresa, indicano che il numero di imprese attive in Italia è 4,665 milioni. La quasi totalità (94,91%) sono imprese con un numero di dipendenti compreso tra 0 e 9, anche definite microimprese, che costituiscono il tessuto imprenditoriale prevalente del Paese e operano nei diversi settori economici ed impiegano 7,704 milioni di lavoratori.
Seguono le piccole imprese (tra 10 e 49 dipendenti) che costituiscono il 4,44% del totale, mentre le medie imprese (tra 50 e 249 dipendenti) sono lo 0,56% del totale. La quota residuale è costituita dalle grandi imprese (almeno 250 dipendenti), che in Italia nel 2022 erano poco più di 4.400. Tuttavia, il loro impatto sull’economia nazionale è rilevante grazie al loro elevato livello di produttività, alla capacità di investimento e al numero di dipendenti che impiegano. Infatti, pur costituendo solo lo 0,09% del numero totale delle imprese italiane, le grandi imprese impiegano più di 4,2 milioni di lavoratori, pari al 23,29% del totale.
Se non si sciolgono i nodi reali, lamentarsi dei bassi salari è come abbaiare alla luna.
